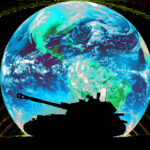In nome del padre. Lo Stato etico di Salvini e Di Maio
Diritti civili, buoni sentimenti, Costituzione Repubblicana, Europa sono alcuni degli ingredienti della salsa con cui le sinistre post governative e quelle orfane di governo provano a rifarsi la faccia e riconquistare i consensi...
Per saperne di più