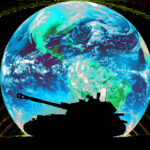L’altro Pride. Contro frontiere e decoro
Giugno è il mese del Pride. La giornata dell’orgoglio delle persone omosessuali, transessuali, queer, bisex, intersex nasce dopo la rivolta di 49 anni fa a a New York. Stanch* di violenze, irrisioni, soprusi della polizia quelli dello Stonewall alzarono la testa e attaccarono la polizia. Il primo Pride fu un riot.
A Torino il Pride è un’imponente sfilata attraversata da decine di migliaia di persone. Ma Stonewall è lontana, lontanissima da Torino.
Il Pride anno dopo anno è diventato un ibrido tra un carnevale, una passerella istituzionale e uno evento commerciale.
C’è sempre meno spazio per le voci critiche, per un approccio intersezionale, per chi vuole che libertà e diritti siano per tutti, anche per gli esclusi dal grande banchetto, per i migranti, i poveri, i rom, i senza casa.
Lo slogan di quest’anno era “Nessun dorma”, una maniera appena accennata di alludere alle componenti omofobe, maschiliste, transfobiche del governo giallo-verde. Senza esagerare, senza permettersi critiche al governo della città e a quello della Regione. In punta di piedi, per non disturbare troppo.
Non poteva essere altrimenti, perché le istituzioni erano in testa al corteo.
La sfilata del 16 giugno è stata organizzata dal Coordinamento Torino Pride con il patrocinio di Comune di Torino, Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Torino Metropolitana, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara. Tra gli sponsor la Coop, la Gtt, Il corpo di polizia municipale della città di Torino.
La sfilata, cui ogni carro entrava solo pagando, è stata tenuta sotto controllo dalla polizia di Stato e dal servizio d’ordine di due compagnie private, i City Angels, noti per la pulizia etnica a San Salvario e l’Hydra Service, i picchiatori prezzolati al servizio del PD, tristemente noti per i loro interventi muscolari contro ogni forma di opposizione sociale. Noi li ricordiamo per il camion dello spezzone anarchico e antimilitarista spaccato il primo maggio 2011, ma i loro bastoni si sono esibiti in molte altre occasioni.
Quest’anno al Torino Pride gli attivist* di “Nessun* Norma!”, il Pride contro frontiere e decoro del 28 giugno hanno distribuito volantini, che sono immediatamente entrati nel mirino della polizia, che li ha circondati pretendendo di sequestrarli, per le immagini satiriche stampate sul retro. Immagini considerate offensive, perché non è lecito burlare ministri e sindaci. Specie se si tratta di Salvini, Fontana e Appendino. Diverse compagn* sono state identificate e minacciate dalla digos. Alla fine gli uomini e le donne della polizia politica si sono accontentat* di sequestrare solo una parte del materiale.
Ma non è finita lì. Più tardi è stato aperto uno striscione in via Po ed acceso qualche fumogeno per attirare l’attenzione. Sullo striscione campeggiava la scritta “Il Pride è rivolta. Contro frontiere, decoro, istituzionalizzazione. Nessun Norma” Lo striscione è stato due volte rimosso dal servizio d’ordine del Pride. Un fumogeno è stato lanciato addosso alle persone.
La repressione al Pride istituzionale ha dato una bella spruzzata di pepe a chi stava organizzando il corteo indecoroso del 28 giugno.
In maggio individui e gruppi diversi, che si erano intrecciati nelle lotte contro le frontiere, gli sgomberi, la repressione hanno cominciato ad incontrarsi per costruire un altro Pride. Una scommessa che ha visto accanto Ah Squeerto e Studenti Indipendenti, Manituana e Federazione Anarchica, Breacktheborder e l’infoshock del Gabrio.
Una scommessa difficile, che si è dovuta scontrare con l’indifferenza e l’ostilità di chi, anche nei movimenti di opposizione sociale, nonostante tutto, preferiva affacciarsi al Pride istituzionale. Non Una di Meno, rete “transfemminista ed intersezionale”, avrebbe potuto portare un contributo importante all’iniziativa, invece si è divisa senza raggiungere una sintesi, ma, nei fatti partecipando attivamente, sia pure in tono minore, solo al Pride istituzionale dove sono stati distribuiti volantini, fatti interventi e portate a spasso le matrioske.
Una brutta scivolata della Rete torinese, preoccupante in un clima politico e culturale sempre più difficile.
Torino si è trasformata da città dell’auto a vetrina di grandi eventi, un grande Luna Park per turisti, mentre le periferie sono in bilico tra riqualificazioni escludenti e un parco giochi per carabinieri, alpini e poliziotti.
E non può che andare peggio. Se Appendino riuscirà ad aggiudicarsi il carrozzone olimpico del 2026, il restyling della città costerà caro a chi non corrisponde ai criteri di decoro urbano.
Sfruttamento, lavori precari e pericolosi, morti in mare, leggi razziste, militari per le strade, guerra sono i tasselli del puzzle che disegna il nostro vivere.
La gente delle periferie sente in bocca il sapore agre di una vita sempre più precaria, cedendo alle tentazioni populiste e nazionaliste, rischiando di scivolare sul declivio della guerra tra poveri.
Il governo della città è stato per decenni nelle mani del Partito Democratico.
Da due anni governano i Cinque Stelle. La nuova sindaca è apprezzata dalle banche e dai padroni.
Bisognava che tutto cambiasse perché ogni cosa restasse come prima. Appendino fa la guerra ai rom, sguinzaglia i vigili urbani a caccia di mendicanti, lavavetri, spacciatori di accendini, senza casa.
Chi aveva creduto alla retorica della democrazia penta stellata sta scoprendo che per i poveri non è cambiato nulla. I posti occupati che non hanno accettato la normalizzazione a Cinque Stelle sono stati sgomberati. La baraccopoli rom di corso Tazzoli è stata demolita per la “sicurezza” degli abitanti gettati in strada.
La retorica della “cittadinanza” partecipativa sceglie chi includere e chi escludere, nel gioco feroce delle poltrone, del potere, delle alleanze.
Appendino prepara la vetrina olimpica, cementifica la città, si congratula con la polizia che arresta gli anarchici… sfila in testa al Pride e benedice le famiglie arcobaleno.
Il 28 giugno l’altro Pride ha attraversato il centro cittadino, nonostante il nuovo questore avesse imposto divieti di sapore squisitamente politico. Piazza Palazzo di città, dove ha sede il comune, è stata chiusa e blindata da Digos e poliziotti in assetto antisommossa. Un blocco risibile di fronte alla folla queer che li fronteggiava, irrideva, mimava. Il segno che i timori per “l’ordine pubblico” erano solo paura di corpi ed identità erranti indisponibili a farsi rinchiudere in una gabbia dorata, dove il prezzo della “libertà” è l’accettazione delle linee di cesura che attraversano il nostro spazio sociale.
Cartelli con le “coppie di fatto” danno il segno di una critica intollerabile per la questura e la prefettura, la lunga mano del governo sui territori.
Chiara Appendino e Lorenzo Fontana, la sindaca gay friendly ed il ministro della famiglia omofobo e maschilista. Merkel ed Erdogan, Di Maio e Salvini, le coppie oscene del teatro politico.
Il corteo, cresciuto lungo il percorso, ha sostato in piazza Castello, percorso via Po e via Accademia tra musica, balli, corpi liberi e interventi. In corso Vittorio è dilagato su tutti e quattro i viali sino alla blindatissima stazione di Porta Nuova, vera frontiera invisibile nel cuore di Torino. Ogni giorno, da mesi, i binari da dove partono i treni diretti in Val Susa sono sorvegliati da pattuglie interforze di poliziotti e militari, che selezionano i passeggeri. Se sei nero, anche se hai un documento in tasca ed un biglietto, ti rimandano indietro. La frontiera con la Francia erige i suoi muri nel cuore di Torino.
Le frontiere sono linee su una mappa. Sottili righe scure fatte di nulla che uomini armati in divisa rendono vere.
Le frontiere dividono e uccidono.
Nel Mediterraneo e in montagna. Nei ghetti dei raccoglitori di frutta e pomodori, nei cantieri dove la sicurezza è un lusso.
Nei tanti interventi durante il corteo abbiamo ricordato Blessing e Mamadou, uccisi dalle frontiere chiuse al Montgenevre, Soumaila Sacko ammazzato dalla lupara al servizio dei padroni.
Le frontiere sono in mezzo a noi. Sono le leggi sul decoro che cacciano i poveri dai luoghi pubblici, sono le leggi sulla proprietà che negano una casa a chi non ce l’ha.
Sono le frontiere tra i sessi, che piegano i corpi e le soggettività erranti alle regole della famiglia, nucleo “etico” che ingabbia le relazioni, fissa i ruoli, nega la possibilità di percorsi individuali fuori dal reticolo patriarcale, statale, religioso.
Il corteo si è concluso con una festa al Valentino benefit per il rifugio autogestito Chez Jesus di Claviere.
Libertà, uguaglianza, solidarietà. I tre principi che costituiscono la modernità, rompendo la gerarchia che modellava l’ordine formale del mondo, hanno il loro lato oscuro, un’ombra lunga fatta di esclusione, discriminazione, violenza.
Questi principi tengono saldamente fuori tanta parte dell’umanità. Poveri, donne, omosessuali, transessuali, bambini, stranieri erano/sono esclusi dall’accesso a questi diritti. La loro universalità, formalmente neutra, è modellata sul maschio adulto, benestante, bianco, eterosessuale. Il resto è margine. Chi non è pienamente umano non può essere “cittadino”, soggetto di diritto.
Chi non è pienamente umano non può aspirare alle libertà degli uomini.
Una libertà regolata, imbrigliata, incasellata. La cultura dominante ne determina le possibilità, le leggi dello Stato ne fissano limiti e condizioni. Per chi ne è escluso si tratta di privilegi, per chi vi è inscritto diviene una gabbia normativa.
Come il matrimonio. Un legame sancito dallo Stato (e dalla chiesa) che fissava la diseguaglianza e l’asservimento delle donne, sottomesse al marito alla cui tutela venivano affidate. Eterne minorenni passavano dalla potestà paterna a quella maritale.
Le lotte che hanno segnato le tante vie della libertà femminile hanno in parte cancellato quella servitù. Ma ne hanno pagato il prezzo. Il prezzo dell’emancipazione femminile è l’adeguamento all’universale, che resta saldamente maschile, bianco, benestante ed eterosessuale.
Lo spazio della sperimentazione, della messa in gioco dei percorsi identitari, tanto radicati nella cultura da sembrare «naturali», tende ad estinguersi, polverizzato dalle cazzutissime donne in divisa, dalle manager in carriera, dal femminismo della differenza che inventa le gerarchie femminili per favorire manovre di lobbing. Tutto deve diventare “normale”, vendibile, controllabile.
Le differenze tra le persone non sono iscritte nella natura o nella cultura, ma offrono una possibilità, la possibilità che ha sempre chi si libera: cogliere le radici soggettive ed oggettive della dominazione per reciderle inventando nuovi percorsi.
Percorsi possibili solo fuori e contro il reticolo normativo stabilito dallo Stato, che, non per caso, nega diritti e tutele alle persone che scelgono di non sposarsi.
La strada del movimento lgbtqi è stata ed è ancora in netta salita. Fascisti e preti continuano le loro crociate per escludere dall’umanità una sua parte. Le discriminazioni, la violenza statale e culturale sono molto forti.
Chi vorrebbe le stesse possibilità degli eterosessuali – adozioni, pensione di reversibilità, diritto alla cura del partner – deve adeguarsi ad un modello rigido di relazione costruita sulla coppia e sui loro figli, alla legalizzazione dei sentimenti, delle passioni, della tenerezza.
Chi sceglie di starne fuori, di fare altre strade, non può avere questi privilegi anche se eterosessuale.
La normalizzazione delle nostre identità erranti è il prezzo per accedere ad alcune libertà che si ottengono solo con il matrimonio, un legame sancito e regolato dallo Stato. È un prezzo che tanti non sono dispost* a pagare.
Abbiamo attraversato la città con la leggerezza di chi si scioglie da vincoli e lacci. Con la stessa leggerezza attraversiamo le nostre vite.
Senza frontiere, che separino i sommersi dai salvati, i cittadini e gli stranieri.
Il percorso di autonomia individuale si costruisce nella sottrazione conflittuale dalle regole sociali imposte dallo Stato e dal capitalismo. La solidarietà ed il mutuo appoggio si possono praticare attraverso relazioni libere, plurali, egualitarie.
Una scommessa che spezza l’ordine. Morale, sociale, economico.
Maria Matteo
Per saperne di più